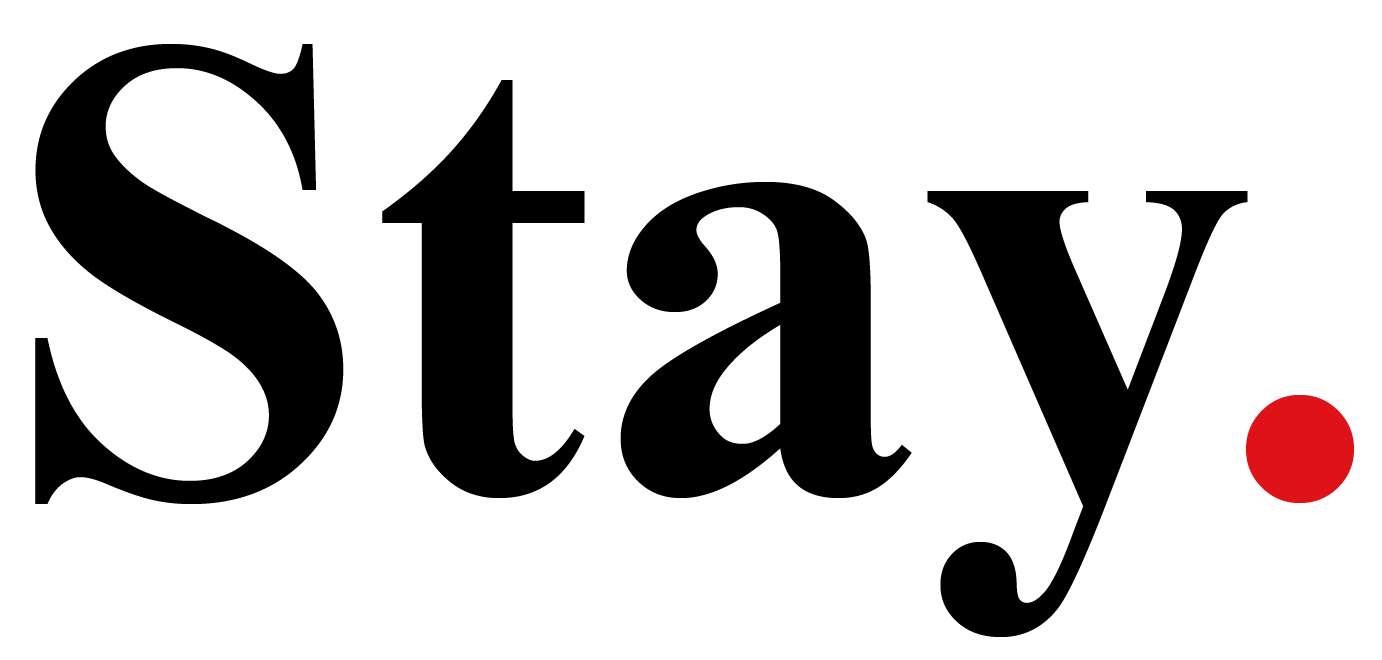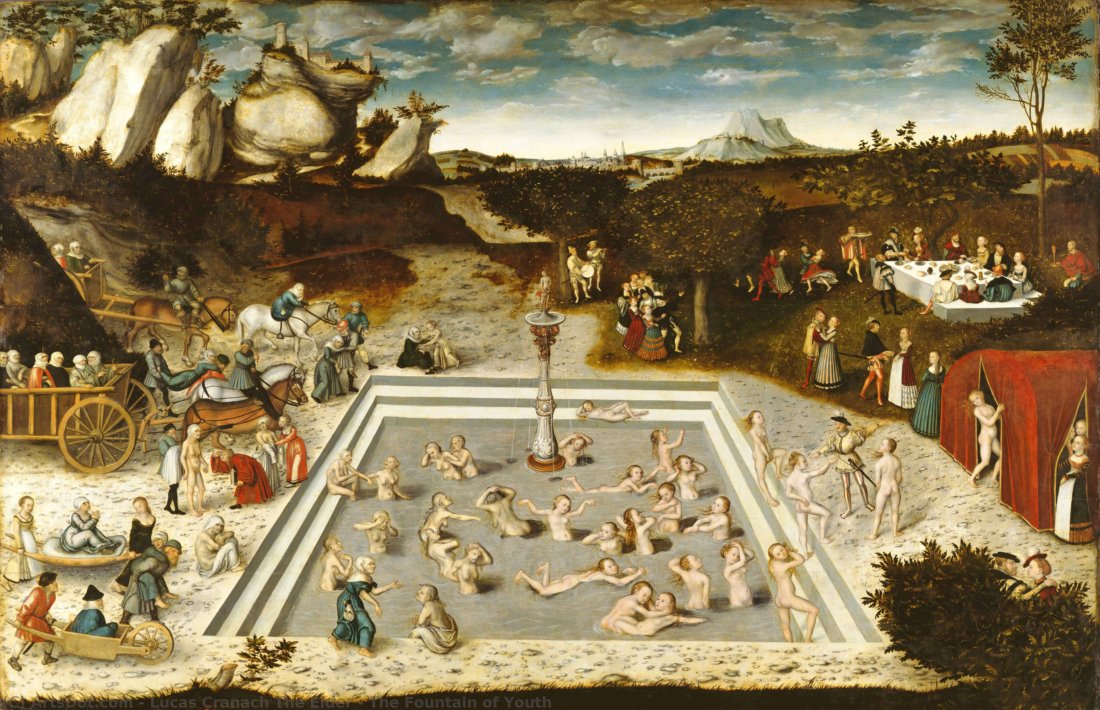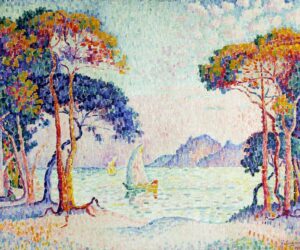Sono in tantissimi, difficile che non diano nell’occhio e ognuno di noi ne conosce almeno uno: può essere l’anziano della nostra comitiva di amici o addirittura uno dei nostri genitori. Li definiscono come eterni Peter Pan e sono quei soggetti che restano ancorati all’adolescenza ben oltre i 18 anni. Nell’ultima decade, gli studi condotti su nuclei familiari e cittadini italiani ne hanno evidenziato un numero così importante da giustificarne la lettura come vero e proprio fenomeno sociale: l’adultescenza.
Adultescenza
s. f. Comportamento proprio di adulti che imitano modi giovanili, compiacendosi di ostentare interessi e stili di vita da adolescenti.
Treccani
Fa pendant con: immaturità, limitatezza, blocco.
Si contrappone a: maturità, evoluzione, intelligenza emotiva.
Tutt’altra cosa rispetto a: giovinezza.
Capiamo perché
Una vecchia sitcom statunitense si intitolava “Crescere che fatica”. Il protagonista era Cory Matthews: un liceale alle prese con le prime lezioni di vita che spalancano la via dell’età adulta. Il titolo italiano, a differenza di quello inglese (Boy meets world), lasciava trasparire una certa difficoltà di fondo nel processo evolutivo che porta un’adolescente a trasformarsi nella propria versione adulta eppure, a quel tempo, era ancora un percorso che si portava a termine abbastanza naturalmente.
Secondo i miei ricordi, infatti, prima della moneta unica e della crisi finanziaria del 2007-2008, i trentenni erano già adulti consolidati, con una rassicurante indipendenza economica e, il più delle volte, già con casa e famiglia.
Oggi trent’anni li ho io e sono ben lontana da questa triade mitologica. Ma non mi dispiacerebbero certe responsabilità, a dispetto di chi se ne tiene accuratamente alla larga e di chi, invece, non le vuole più (anche la crisi di mezza età sta diventando un fenomeno consistente).
A quanto sembra dai dati raccolti dai sociologi e dai pedagoghi, il nostro Paese brulica di 40/50/60enni che hanno fermato il proprio calendario emotivo al 18esimo compleanno. Sono molte le motivazioni: una scarsa indipendenza economica, un eccesso di consumismo a scapito della possibilità di affrontare spese quotidiane, l’ansia di prendersi delle responsabilità o la paura di impegnarsi in modo duraturo.
Dal modo di parlare, a quello di vestire (e questo meriterebbe una trattazione dedicata), all’interpretazione della socialità e all’utilizzo dei social network, l’adultescente ostenta uno stile di vita palesemente asincrono rispetto all’età anagrafica, in uno stato di perenne ricerca edonistica.
Ma come si inverte questo processo di infantilizzazione della società? Secondo la professoressa Elena Marescotti, docente del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara e vincitrice del Premio Italiano di Pedagogia 2021, nel particolare momento storico che l’Italia sta attraversando, si rende necessaria una specifica educazione all’adultità:
la condizione adulta è il banco di prova più significativo e pregnante dell’avventura educativa: è nel modo di essere adulti che si ha prova tangibile del cos’è e a cosa serve l’educazione stessa. E questo in un’ottica che non può solo essere riferita alla dimensione individuale […] L’educazione infatti è affare di tutta una comunità. Allo stesso modo, anche l’immaturità adulta è un problema sociale, perché mina un’intera collettività […].
Un po’ mi viene da sorridere ripensando ai miei nonni: se avessi fatto un discorso del genere a loro, credo che non lo avrebbero proprio compreso. Io stessa rimango incredula difronte allo smisurato e multigenerazionale desiderio di immaturità che permea, ad esempio, la città in cui vivo.
E qui sotto?! Un elenco quasi random di parole da tenere a mente
Dagli archivi di Stay.
Termine attualissimo che cela una fitta rete di controversie. Da un articolo sul rapporto malsano che i giovani neo genitori instaurano tra i figli e i social network.
Zuccherini per i nostalgici
XKE’. Si scriveva con tre lettere – a volte anche solo con due – ed era l’estrema sintesi del nostro classico perché (sicuramente più elegante e bello). Si è detto che questo genere di scrittura abbia favorito il proliferare di errori grammaticali sui testi dei giovani studenti. Io non sono mai stata così dura, perché in fondo se uso il simbolo “5” non mi dimentico che si scrive anche “cinque”. Non posso nemmeno negare l’esistenza di tutti gli “ai” senza “h” che mi è capitato di leggere negli ultimi 15 anni…Ma che dire? Lego quel xké al mio primo telefono cellulare, alla prima sim che ho comprato, ai primi (costosissimi) sms che ho inviato e non posso non sentire quel caldo pizzico di nostalgia che tanto agogno nelle frenetiche giornate della SocietsApp.